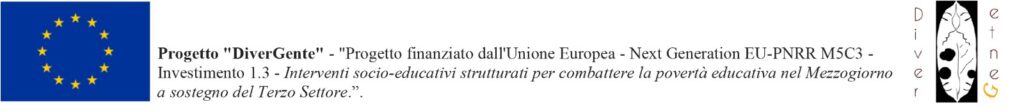Il sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione economica e sociale: sfide psicosociali e comunitarie
Il sostegno alla genitorialità rappresenta un elemento cruciale per la promozione del benessere infantile e familiare. Tuttavia, in contesti di deprivazione economica e sociale, tale sostegno si confronta con sfide complesse, legate non solo alla scarsità di risorse materiali, ma anche alla vulnerabilità psicosociale delle famiglie coinvolte. Queste difficoltà non sono solo individuali, ma si inseriscono in una cornice comunitaria e strutturale che amplifica le disuguaglianze e ostacola l’efficacia degli interventi.
La genitorialità è un processo dinamico influenzato da molteplici fattori contestuali. Nei contesti di povertà, la capacità genitoriale può essere compromessa da stress cronico, isolamento sociale, e difficoltà di accesso ai servizi. Le famiglie a basso reddito, infatti, sono più esposte a condizioni abitative precarie, disoccupazione, e bassi livelli di istruzione, che impattano negativamente sulla qualità della relazione genitori-figli (Masten & Coatsworth, 1998).

Le ricerche mostrano come la povertà infantile sia associata a maggiori rischi di problemi comportamentali, ritardi nello sviluppo e difficoltà scolastiche, specialmente in assenza di un supporto genitoriale adeguato (Brooks-Gunn & Duncan, 1997). In tali contesti, i genitori possono vivere un conflitto tra il desiderio di essere presenti e il bisogno di lavorare in condizioni precarie e flessibili, spesso con orari incompatibili con le esigenze familiari.
I servizi di sostegno alla genitorialità in contesti svantaggiati devono affrontare numerose criticità. In primo luogo, esiste spesso una distanza culturale e simbolica tra operatori sociali e famiglie, che può generare sfiducia e resistenza all’intervento (Serbati & Milani, 2013). Inoltre, le politiche sociali tendono a essere frammentate, episodiche e reattive piuttosto che preventive e integrate, rendendo difficile costruire percorsi continuativi di accompagnamento.
Una delle principali criticità è la tendenza alla “colpevolizzazione” delle famiglie in difficoltà, che rischia di trasformare l’intervento in un controllo piuttosto che in un sostegno (Donati & Andrenacci, 2007). Ciò può compromettere la relazione di fiducia, fondamentale per attivare processi di empowerment e capacitazione genitoriale.

Per rispondere in modo adeguato alle sfide del sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione, è necessario adottare un approccio psicosociale e comunitario integrato. Tale approccio valorizza le risorse presenti nelle famiglie e nelle comunità, promuove la partecipazione attiva dei genitori e riconosce l’importanza del contesto socio-culturale (Bronfenbrenner, 1979).
In particolare, interventi basati sulla comunità, come i centri per le famiglie, i gruppi di auto-mutuo aiuto e i progetti educativi territoriali, si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’isolamento sociale, favorire il supporto tra pari e migliorare le competenze genitoriali (Milani & Ius, 2010). Fondamentale è anche la formazione degli operatori alla competenza interculturale e alla comunicazione empatica, per costruire relazioni basate sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità.
Affrontare le difficoltà del sostegno alla genitorialità in ambienti deprivati richiede una visione sistemica e intersettoriale. Le politiche pubbliche dovrebbero investire in servizi integrati, accessibili e culturalmente sensibili, capaci di lavorare in rete con scuole, servizi sanitari, e realtà del terzo settore. È inoltre essenziale coinvolgere le famiglie come soggetti attivi del cambiamento, riconoscendo e valorizzando le loro competenze e potenzialità.
Infine, è importante promuovere la ricerca partecipata e la valutazione degli interventi, per adattare le strategie ai bisogni reali delle comunità e favorire processi di apprendimento continuo.
Il sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione economica e sociale rappresenta una sfida complessa ma cruciale per la promozione dell’equilità e del benessere. Richiede un cambiamento di paradigma: da un approccio centrato sul deficit a uno orientato alla capacitazione, che riconosca il valore delle relazioni, delle reti e della partecipazione comunitaria.
Bibliografia
- Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Harvard University Press.
- Brooks-Gunn, J., & Duncan, G. J. (1997). The effects of poverty on children. The Future of Children, 7(2), 55-71.
- Donati, P., & Andrenacci, L. (2007). Sociologia della famiglia. Laterza.
- Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998). The development of competence in favorable and unfavorable environments. American Psychologist, 53(2), 205-220.
- Milani, P., & Ius, M. (2010). La progettazione educativa e sociale nella comunità. Carocci.
- Serbati, S., & Milani, P. (2013). Valutare la genitorialità in contesti psicosociali. Interazioni, 1, 5-19.
-
Progetto “DiverGente”: un report sul Modulo di Visite Domiciliari
-
Gruppi di sostegno alla genitorialità nei quartieri popolari di Napoli: il caso del Progetto Divergente
-
Napoli e la sfida contro la povertà educativa: un progetto sociale per far emergere la creatività dei bambini
-
Modelli di intervento domiciliare per il sostegno alla genitorialità: prospettive ed esperienze
-
Outdoor School a Napoli: un’aula a cielo aperto per crescere con la città
-
Il sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione economica e sociale: sfide psicosociali e comunitarie
-
Teatroterapia e Teatro Sensoriale: Strumenti Terapeutici per lo Sviluppo Psichico dei Bambini (5-10 anni)
Il sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione economica e sociale: sfide psicosociali e comunitarie
 Il sostegno alla genitorialità rappresenta un elemento cruciale per la promozione del benessere infantile e familiare. Tuttavia, in contesti di deprivazione economica e sociale, tale sostegno si confronta con sfide complesse, legate non solo alla scarsità di risorse materiali, ma anche alla vulnerabilità psicosociale delle famiglie coinvolte. Queste difficoltà non sono solo individuali, ma si inseriscono in una cornice comunitaria e strutturale che amplifica le disuguaglianze e ostacola l’efficacia degli interventi.
La genitorialità è un processo dinamico influenzato da molteplici fattori contestuali. Nei contesti di povertà, la capacità genitoriale può essere compromessa da stress cronico, isolamento sociale, e difficoltà di accesso ai servizi. Le famiglie a basso reddito, infatti, sono più esposte a condizioni abitative precarie, disoccupazione, e bassi livelli di istruzione, che impattano negativamente sulla qualità della relazione genitori-figli (Masten & Coatsworth, 1998).
Il sostegno alla genitorialità rappresenta un elemento cruciale per la promozione del benessere infantile e familiare. Tuttavia, in contesti di deprivazione economica e sociale, tale sostegno si confronta con sfide complesse, legate non solo alla scarsità di risorse materiali, ma anche alla vulnerabilità psicosociale delle famiglie coinvolte. Queste difficoltà non sono solo individuali, ma si inseriscono in una cornice comunitaria e strutturale che amplifica le disuguaglianze e ostacola l’efficacia degli interventi.
La genitorialità è un processo dinamico influenzato da molteplici fattori contestuali. Nei contesti di povertà, la capacità genitoriale può essere compromessa da stress cronico, isolamento sociale, e difficoltà di accesso ai servizi. Le famiglie a basso reddito, infatti, sono più esposte a condizioni abitative precarie, disoccupazione, e bassi livelli di istruzione, che impattano negativamente sulla qualità della relazione genitori-figli (Masten & Coatsworth, 1998). Il sostegno alla genitorialità rappresenta un elemento cruciale per la promozione del benessere infantile e familiare. Tuttavia, in contesti di deprivazione economica e sociale, tale sostegno si confronta con sfide complesse, legate non solo alla scarsità di risorse materiali, ma anche alla vulnerabilità psicosociale delle famiglie coinvolte. Queste difficoltà non sono solo individuali, ma si inseriscono in una cornice comunitaria e strutturale che amplifica le disuguaglianze e ostacola l’efficacia degli interventi.
La genitorialità è un processo dinamico influenzato da molteplici fattori contestuali. Nei contesti di povertà, la capacità genitoriale può essere compromessa da stress cronico, isolamento sociale, e difficoltà di accesso ai servizi. Le famiglie a basso reddito, infatti, sono più esposte a condizioni abitative precarie, disoccupazione, e bassi livelli di istruzione, che impattano negativamente sulla qualità della relazione genitori-figli (Masten & Coatsworth, 1998).

Le ricerche mostrano come la povertà infantile sia associata a maggiori rischi di problemi comportamentali, ritardi nello sviluppo e difficoltà scolastiche, specialmente in assenza di un supporto genitoriale adeguato (Brooks-Gunn & Duncan, 1997). In tali contesti, i genitori possono vivere un conflitto tra il desiderio di essere presenti e il bisogno di lavorare in condizioni precarie e flessibili, spesso con orari incompatibili con le esigenze familiari.
I servizi di sostegno alla genitorialità in contesti svantaggiati devono affrontare numerose criticità. In primo luogo, esiste spesso una distanza culturale e simbolica tra operatori sociali e famiglie, che può generare sfiducia e resistenza all’intervento (Serbati & Milani, 2013). Inoltre, le politiche sociali tendono a essere frammentate, episodiche e reattive piuttosto che preventive e integrate, rendendo difficile costruire percorsi continuativi di accompagnamento.
Una delle principali criticità è la tendenza alla “colpevolizzazione” delle famiglie in difficoltà, che rischia di trasformare l’intervento in un controllo piuttosto che in un sostegno (Donati & Andrenacci, 2007). Ciò può compromettere la relazione di fiducia, fondamentale per attivare processi di empowerment e capacitazione genitoriale.

 Per rispondere in modo adeguato alle sfide del sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione, è necessario adottare un approccio psicosociale e comunitario integrato. Tale approccio valorizza le risorse presenti nelle famiglie e nelle comunità, promuove la partecipazione attiva dei genitori e riconosce l’importanza del contesto socio-culturale (Bronfenbrenner, 1979).
In particolare, interventi basati sulla comunità, come i centri per le famiglie, i gruppi di auto-mutuo aiuto e i progetti educativi territoriali, si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’isolamento sociale, favorire il supporto tra pari e migliorare le competenze genitoriali (Milani & Ius, 2010). Fondamentale è anche la formazione degli operatori alla competenza interculturale e alla comunicazione empatica, per costruire relazioni basate sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità.
Per rispondere in modo adeguato alle sfide del sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione, è necessario adottare un approccio psicosociale e comunitario integrato. Tale approccio valorizza le risorse presenti nelle famiglie e nelle comunità, promuove la partecipazione attiva dei genitori e riconosce l’importanza del contesto socio-culturale (Bronfenbrenner, 1979).
In particolare, interventi basati sulla comunità, come i centri per le famiglie, i gruppi di auto-mutuo aiuto e i progetti educativi territoriali, si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’isolamento sociale, favorire il supporto tra pari e migliorare le competenze genitoriali (Milani & Ius, 2010). Fondamentale è anche la formazione degli operatori alla competenza interculturale e alla comunicazione empatica, per costruire relazioni basate sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità. Per rispondere in modo adeguato alle sfide del sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione, è necessario adottare un approccio psicosociale e comunitario integrato. Tale approccio valorizza le risorse presenti nelle famiglie e nelle comunità, promuove la partecipazione attiva dei genitori e riconosce l’importanza del contesto socio-culturale (Bronfenbrenner, 1979).
In particolare, interventi basati sulla comunità, come i centri per le famiglie, i gruppi di auto-mutuo aiuto e i progetti educativi territoriali, si sono dimostrati efficaci nel ridurre l’isolamento sociale, favorire il supporto tra pari e migliorare le competenze genitoriali (Milani & Ius, 2010). Fondamentale è anche la formazione degli operatori alla competenza interculturale e alla comunicazione empatica, per costruire relazioni basate sul rispetto e sulla valorizzazione delle diversità.
Affrontare le difficoltà del sostegno alla genitorialità in ambienti deprivati richiede una visione sistemica e intersettoriale. Le politiche pubbliche dovrebbero investire in servizi integrati, accessibili e culturalmente sensibili, capaci di lavorare in rete con scuole, servizi sanitari, e realtà del terzo settore. È inoltre essenziale coinvolgere le famiglie come soggetti attivi del cambiamento, riconoscendo e valorizzando le loro competenze e potenzialità.
Infine, è importante promuovere la ricerca partecipata e la valutazione degli interventi, per adattare le strategie ai bisogni reali delle comunità e favorire processi di apprendimento continuo.
Il sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione economica e sociale rappresenta una sfida complessa ma cruciale per la promozione dell’equilità e del benessere. Richiede un cambiamento di paradigma: da un approccio centrato sul deficit a uno orientato alla capacitazione, che riconosca il valore delle relazioni, delle reti e della partecipazione comunitaria.
Bibliografia
- Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Harvard University Press.
- Brooks-Gunn, J., & Duncan, G. J. (1997). The effects of poverty on children. The Future of Children, 7(2), 55-71.
- Donati, P., & Andrenacci, L. (2007). Sociologia della famiglia. Laterza.
- Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998). The development of competence in favorable and unfavorable environments. American Psychologist, 53(2), 205-220.
- Milani, P., & Ius, M. (2010). La progettazione educativa e sociale nella comunità. Carocci.
- Serbati, S., & Milani, P. (2013). Valutare la genitorialità in contesti psicosociali. Interazioni, 1, 5-19.
-
Progetto “DiverGente”: un report sul Modulo di Visite Domiciliari
-
Gruppi di sostegno alla genitorialità nei quartieri popolari di Napoli: il caso del Progetto Divergente
-
Napoli e la sfida contro la povertà educativa: un progetto sociale per far emergere la creatività dei bambini
-
Modelli di intervento domiciliare per il sostegno alla genitorialità: prospettive ed esperienze
-
Outdoor School a Napoli: un’aula a cielo aperto per crescere con la città
-
Il sostegno alla genitorialità in contesti di deprivazione economica e sociale: sfide psicosociali e comunitarie
-
Teatroterapia e Teatro Sensoriale: Strumenti Terapeutici per lo Sviluppo Psichico dei Bambini (5-10 anni)
ME.TI. © 2025
tutti i diritti sono riservati
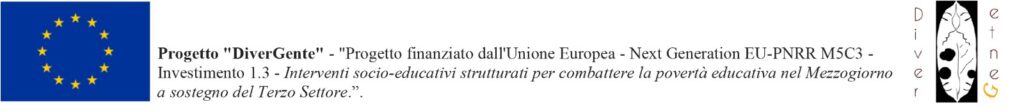
tutti i diritti sono riservati
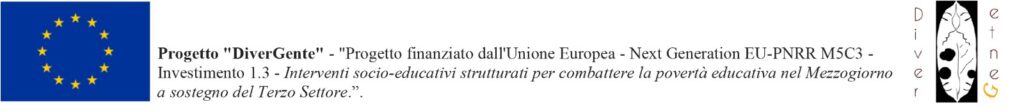
tutti i diritti sono riservati